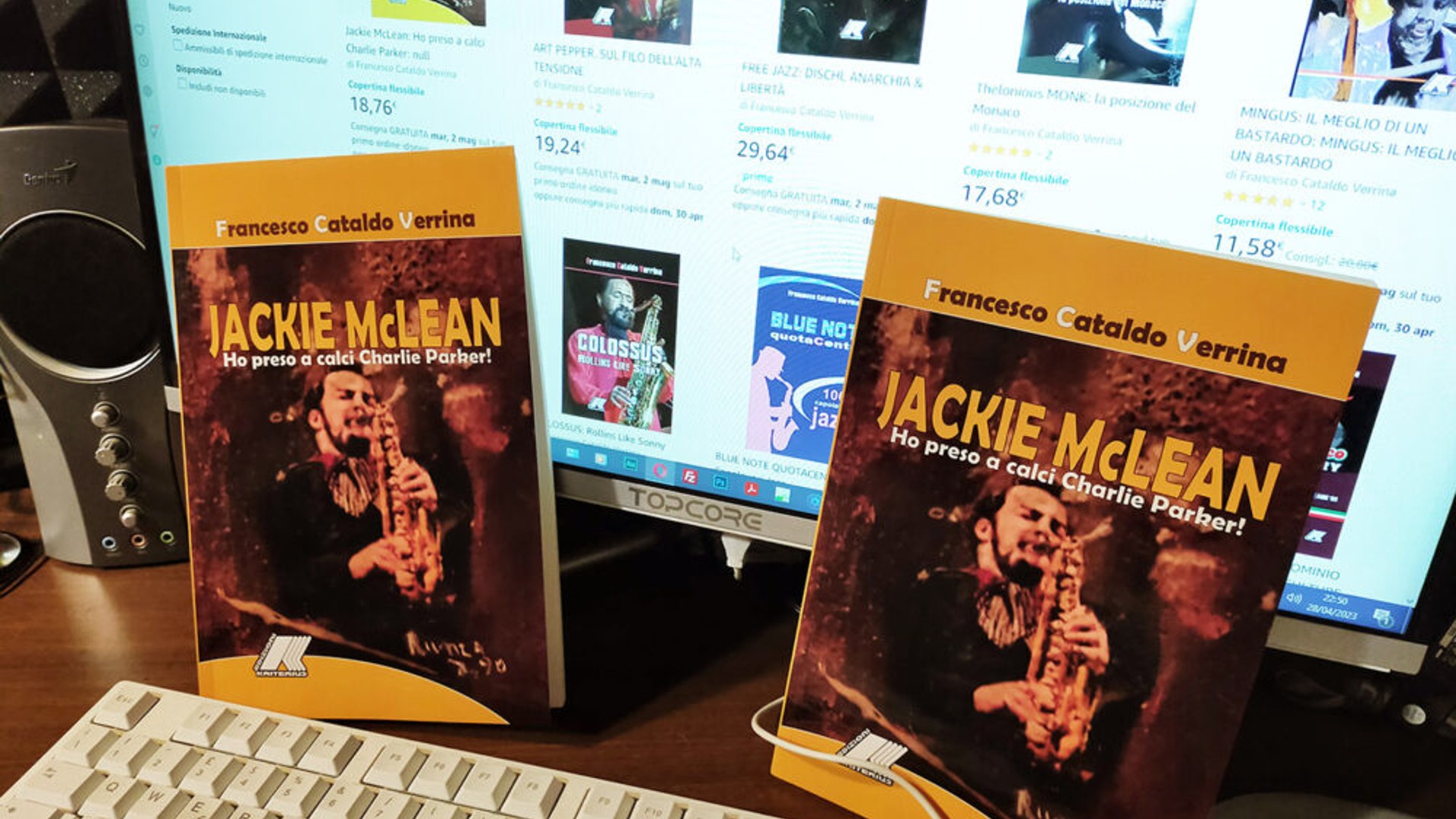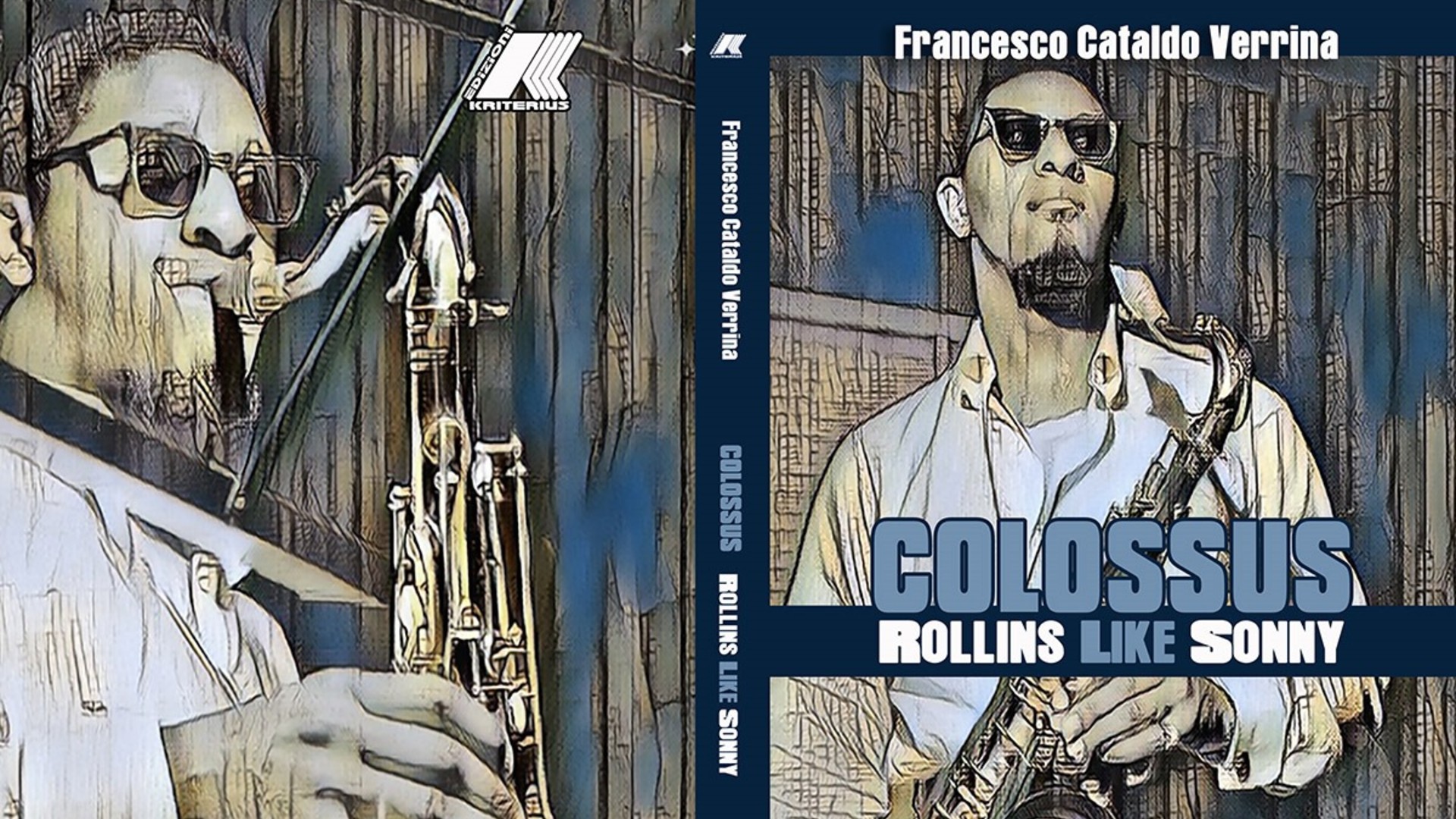Jazz Around ha incontrato Francesco Cataldo Verrina in occasione della presentazione del suo nuovo libro concepito con la solita tecnica narrativa, dove i dischi diventano i capitoli del racconto intercalati ed arricchiti da notizie biografiche ed ambientali.
Ciao Francesco, da cosa nasce l’interesse per Lee Morgan e dove risiede il fascino del personaggio?
A proposito di Morgan si potrebbe parlare di un doppio fascino: quello dell’arista e quello del personaggio dalla vita sregolata. Tu sai bene che la natura umana subisce sovente il fascino di quella che viene definita dagli psicologi «collisione tra arte ed eccesso». La storia degli uomini è lastricata di eroi romantici, generalmente vittime della stessa arte che praticavano e martiri a causa di una vita veloce, talvolta scapigliata e scapestrata, condizionata proprio dal quel talento artistico che li aveva resi celebri e sul cui altare si erano immolati. Nel XX secolo l’eroe per eccellenza assume un tratto ancora più «maudit»: sono numerosi quelli che hanno costellato il mondo del cinema e della musica moderna. Egli, ossia l’eroe, non deve necessariamente aver vissuto una vita nobile, bensì un’esistenza piena di iniziali promesse, che finisce per essere stroncata da un overdose o per un eccesso di dipendenza da alcool, stupefacenti o sesso promiscuo e sfrenato, perfino violenza. La lista sarebbe davvero lunga.
Tu quindi ritieni che la l’esistenza caotica e dissoluta di Lee sia altrettanto importante quanto quella musicale a livello di fascinazione?
A livello di narrazione diventa importantissima ed allarga i contorni dell’uomo-personaggio. Consentimi anche un piccolo preambolo che ho fatto nell’introduzione del libro. L’elemento collidente di cui sopra, consiste proprio nel fatto che mentre il pubblico, specie quello dei benpensanti, mediamente, non approva l’uso di sostanze illecite o l’ostentazione di atteggiamenti oltraggiosi per la morale comune, il fascino di tali personaggi ha finito per soggiogare ogni preconcetto, lasciando ai più attenti il compito di scoprire che cosa spingesse talenti così prodigiosi a comportamenti tanto estremi. Il giovane Morgan era quanto di più lontano si possa immaginare da uno stile di vita dissipata e negletta. Il padre, la madre e la sorella, tutti musicisti dilettanti, erano assidui frequentatori della chiesa ed avevano fornito al talento di famiglia un solido sostegno educativo e morale. Lee era uno studente modello ed un abile pianista: si avvicinò alla tromba solo all’età di tredici anni, bruciando tutte le tappe, tanto che, pur frequentando ancora le scuole superiori, divenne presto un habitué della vivacissima scena jazz di Filadelfia.
Leggendo il tuo libro si capisce che se Morgan non avesse incontrato Art Blakey, non solo la sua carriera, ma perfino la sua avita avrebbe preso una piega differente?
Sappiamo che Lee Morgan cadde presto nelle spire della dipendenza: Art Blakey ed il suo entourage facevano proseliti. Le regole, a parte quelle musicali, erano le non regole; soprattutto in quell’ambiente era difficile sfuggire a taluni eccessi. Ad un certo punto, ci fu anche una sottile complicità da parte del pubblico convinto dell’assioma: jazz uguale eccessi o hard-bop uguale nero-drogato. La concezione parkeriana che gli stupefacenti ampliassero lo spetto percettivo, moltiplicando la sensibilità dell’individuo «strafatto» verso la musica e, nella vulgata, l’insana idea che facendo uso di narcotici tutti i musicisti potessero suonare come Bird, disseminò il cammino del bop di molti cadaveri, talvolta neppure eccellenti.
In effetti, c’è tutta una letteratura in proposito…
Nella biografia «Lee Morgan: His Life, Music and Culture», Tom Perchard, professore di musica alla Goldsmith’s University di Londra, racconta che quando il trombettista ed il pianista Bobby Timmons entrarono a far parte dei Messengers, Blakey disse loro: «Vi farò accendere in due settimane». E mantenne la parola. «Art Blakey era famoso per questo», raccontò un musicista anonimo citato da Perchard. «Era il modo in cui pagava molti ragazzi. In altre parole, dava loro la droga e quando era il momento di incassare (dopo un concerto), si prendeva tutti i soldi lui». Un altro biografo di Morgan, Jeffrey S. McMillan, in «Delightfulee», cita Kiko Yamamoto, riportando le parole della modella e ballerina che Lee aveva sposato a Chicago: «Era una brutta dipendenza la sua. Alcune persone come Art, per esempio, l’hanno sempre controllata, non ha mai preso il sopravvento sulla loro vita».
Però poi ad un certo punto arrivò un’altra donna che sembrava potesse essere per Lee un’ancora di salvezza e per un certo periodo riusci ad allontanarlo dal vizio e dalla vita randagia?
Certamente, questa donna lo toglierà dalla miseria, dalla sporcizia, dalla strada e, presto, si dichiarerà sua moglie, nonostante non l’avesse mai sposato. Costei lo accoglierà in casa, lo curerà aiutandolo a disintossicarsi, per quanto il trombettista non riusci mai a risollevarsi completamente. Fortunatamente il metadone diede i suoi frutti riconciliandolo almeno, apparentemente, con il mondo. Quella nuova vita sembrava comunque un’ennesima opportunità. Morgan tornò a incidere dischi ed a suonare dal vivo, perfino a portare il suo messaggio nelle scuole. Nuovamente, dunque, nell’occhio del ciclone, ancora soldi, successo e collaborazioni importanti, ma la gratitudine per un dono ricevuto non fa parte della la natura umana. Non è possibile farsi beffe del destino se ti ha riservato un triste epilogo. Nel senso che questa donna, di nome Helen More, lo ucciderà, dopo una scenata di gelosia alla fine di un concerto. Va da sé che la vita di Lee Morgan risulti piuttosto affascinante proprio perché possiede i tratti di un plot cinematografica, ma è il trombettista che passa alla storia, per la sua musica, le sue performance e i suoi dischi, i quali sono stati la fonte d’ispirazione principale per questo libro, da non considerare assolutamente una biografia, ma una monografia, ossia uno studio ragionato sul personaggio in maniera non necessariamente cronologica.
A proposito, musicalmente parlando, come collochi Lee Morgan per importanza e per stile?
Lee Morgan è considerato, all’unanimità, come uno dei più importanti trombettisti del dopoguerra, da collocare in un determinato ambito stilistico, ossia l’hard bop, di cui è stato forse la massima espressione, nell’accezione più stretta del termine. C’è un dettaglio non trascurabile: Lee Morgan, intorno ai vent’anni, almeno prima di soccombere al vizio dell’eroina, era in grado di suonare costantemente «full barrel», senza mai perdere il contatto con la superficie sonora, in forma e sostanza, indipendentemente dal registro, dal tempo e dalla complessità melodica. Sebbene Morgan fosse un trombettista più spettacolare e più dotato tecnicamente di Miles Davis o di Freddie Hubbard, con le dovute differenze, in quegli anni, le sue produzioni non sembravano lasciare un’impronta così duratura sugli ascoltatori, a parte il vendutissimo «The Sidewinder». A partire da «Search For A New Land» egli avrebbe tenuto a freno l’esuberanza giovanile del suo indomito stile, distillando alcune opere più riflessive, persino minimaliste, che fornivano precise indicazioni su ciò che il trombettista avrebbe potuto diventare, se non fosse morto prematuramente.
Tu sostieni che il suo rapporto con la Blue Note fu piuttosto difficile ed altalenante. Trovi che abbia condizionato certe scelte compositive del trombettista?
Va detto, per verità storica, che la Blue Note, nonostante abbia prodotto una serie interminabile di capolavori, era sempre in difficoltà economiche e sull’orlo di un tracollo finanziario. Sovente i dischi che vendevano bene, andavano a finanziare altri progetti a rischio, tentando di compensare taluni insuccessi commerciali, che nulla avevano a che fare con il livello qualitativo o artistico di certe opere. Non caso fra il 1956 ed il 1963, pur essendo considerato un musicista importante in casa Blue Note, il rapporto del trombettista con l’etichetta di Alfred Lion e Francis Wolff fu piuttosto inquieto ed altalenante: in quel lasso di tempo Lee non raggiunse mai un determinato livello di vendite e un traguardo commerciale soddisfacente. Infatti, tra Morgan e la Blue Note ci fu una specie di iniziale amore-odio di lascia e piglia ed alcuni suoi album uscirono con ben altre quattro differenti etichette: Savoy, Speciality, Vee-Jay e Jazzland.

Però ad un certo punto arrivò «The Sidewinder», a tutt’oggi considerato fra i capolavori del jazz di ogni epoca?
Infatti, l’arrivo nel 1963 di «The Sidewinder» mise economicamente le cose in pari per la gioia di tutti, tamponando vecchie perdite e producendo ingenti guadagni. L’album fu una manna dal cielo per Morgan e Lion, ma in fondo non possedeva nulla di innovativo, il singolo era un trastullo per juke-box e l’intero album snocciolava l’abecedario dell’hard bop, terreno estremamente congeniale al trombettista. Partorito durante una congiuntura astrale favorevole «The Sidewinder», per gli amanti del boogaloo, era come un luna park, una giostra inarrestabile che girava su sé stessa senza mai fermarsi. Fatto sta che, in quel momento, il jazz stava andando in tutt’altra direzione. Dunque, non fu facile bissarne il successo (che non venne mai eguagliato) e tutto ciò produsse molta frustrazione in ambo i contraenti, ossia fra l’etichetta Blue Note e Lee Morgan.
Da quanto si evince dal tuo libro la storia di Lee Morgan ruota tutta intorno a al suo capolavoro discografico e alla frustrazione di non riuscire a produrre un follow-up altrettanto impattante sul mercato. Oppure non è proprio così?
Bisogna distinguere fra arte come produzione ed arte come espressione. A mio avviso Morgan ha fatto dischi superiori a «The Sidewinder», ma non riusci ad uscire mai dalla stereotipo dell’hard bop a presa rapida, anche per colpa della pessima gestione da parte della Blue Note, però il discorso sarebbe lungo: ho dedicato un libro all’etichetta di Alfred Lion. Per intenderci, prendiamo «Search For The New Land» che potrebbe essere letto come l’inno generico ad una terra ideale; un titolo che, in maniera implicita, si lega ai concetti del movimento di liberazione già presenti in «India» e «Africa» di John Coltrane, mentre la struttura ritmico-armonica aperta tenta di svecchiare il vernacolo jazzistico in maniera radicale come «Ascension» di Coltrane o «Free Jazz» di Ornette Coleman, pur usando concetti e lemmi sonori differenti. Diceva Sun Ra: «Ci sono altri mondi (di cui non vi hanno mai parlato)». A parte il riferimento del Santone ad altre galassie, il jazz di quegli anni tentava di scoprire soprattutto altri universi sonori e Lee Morgan cercava di andare oltre il boogaloo, ma veniva puntualmente frenato, anche a causa della sua vita dissoluta che lo portava spesso a fare compromessi ed accettare le regole del mercato.
Quali sono dunque, a tuo avviso, a parte «The Sidewinder», gli album più rappresentativi di Lee Morgan?
Non amo molto le classifiche per la serie «The Best Of», i «Greatest Hits» o la riduzione bignamistica delle discografie. Nel libro analizzo dettagliatamente quasi quaranta dischi di Morgan che ritengo tutti fondamentali per la sua affermazione e relativa evoluzione, alcuni di questi sono senz’altro superiori a «The Sidewinder», specie quelli concepiti nell’ultimo periodo. Vanno comunque ascoltati tutti per avere un quadro completo dell’artista e dell’uomo con le sue fissazioni, le sue paturnie e le sue inquietudini.
Alcuni sostengono che se Lee Morgan fosse vissuto a lungo avrebbe praticato altre tipologie di jazz, oltrepassando il ristretto ambito dell’hard bop?
Sicuramente sì, ne parlo anch’io nel libro, però bisogna stare attenti a non ragionare troppo con il senno di poi: ognuno ha un destino segnato. Ad esempio, Charlie Parker le cose migliori le ha fatte prima dei trent’anni, John Coltrane è morto a quarant’anni, Eric Dolphy a trentasei. Per ciascuno di loro la domanda è sempre stata la stessa: e se fossero vissuti di più? Sono tanti i jazzisti che, a partire dagli anni Settanta, hanno preso altre strade, spesso condizionati dal mercato o dalle tendenze del momento, ma pochi hanno dimostrato di avere la pelle del vero mutante genetico al pari di Miles Davis. Molte considerazioni in merito nascono da un disco del 1970, «Live At The Lighthouse», in cui l’approccio di Morgan risulta assai differente dal tradizionale marchio di fabbrica allontanandosi dalle strutture blues e dai cambi regolari per muoversi su armonie più libere ed aperte. All’epoca dei fatti, la Blue Note aveva organizzato una festa di apertura per la ripresa del live e per il ritrovato Morgan, ma le registrazioni iniziarono solo alla fine della seconda settimana. L’arrivo di Bennie Maupin, al posto di George Coleman, determinò un differente assetto nel line-up, e non solo dal punto di vista esecutivo: il subentrante Maupin portò materiale inedito e stimolante, lontano dal vecchio repertorio a base di blues-soul-jazz su cui il trombettista aveva impostato i suoi concerti. Sebbene la band avesse conservato parte del repertorio, le composizioni di Maupin spinsero il convoglio verso un’altra direzione.
Per concludere, a chi consiglieresti il tuo libro?
Sarei sciocco se non ti dicessi: a tutti! In verità i miei libri non sono rivolti ai laudatores temporis acti, ossia ai nostalgici, oppure a coloro che sanno tutto o che almeno credono di sapere ogni cosa, a prescindere; né tanto meno nascono per sollevare un dibattito fra intellettuali ed ex-freakkettoni; per contro sono rivolti ai musicisti, agli appassionati di jazz a vari livelli, studenti, collezionisti di dischi, soprattutto a quanti intendono conoscere non solo il segno zodiacale, chi erano i vicini di casa o quante volte si lavava un artista, ma che cosa contengano effettivamente il loro dischi. Diciamo che sono libri per «il popolo del jazz».