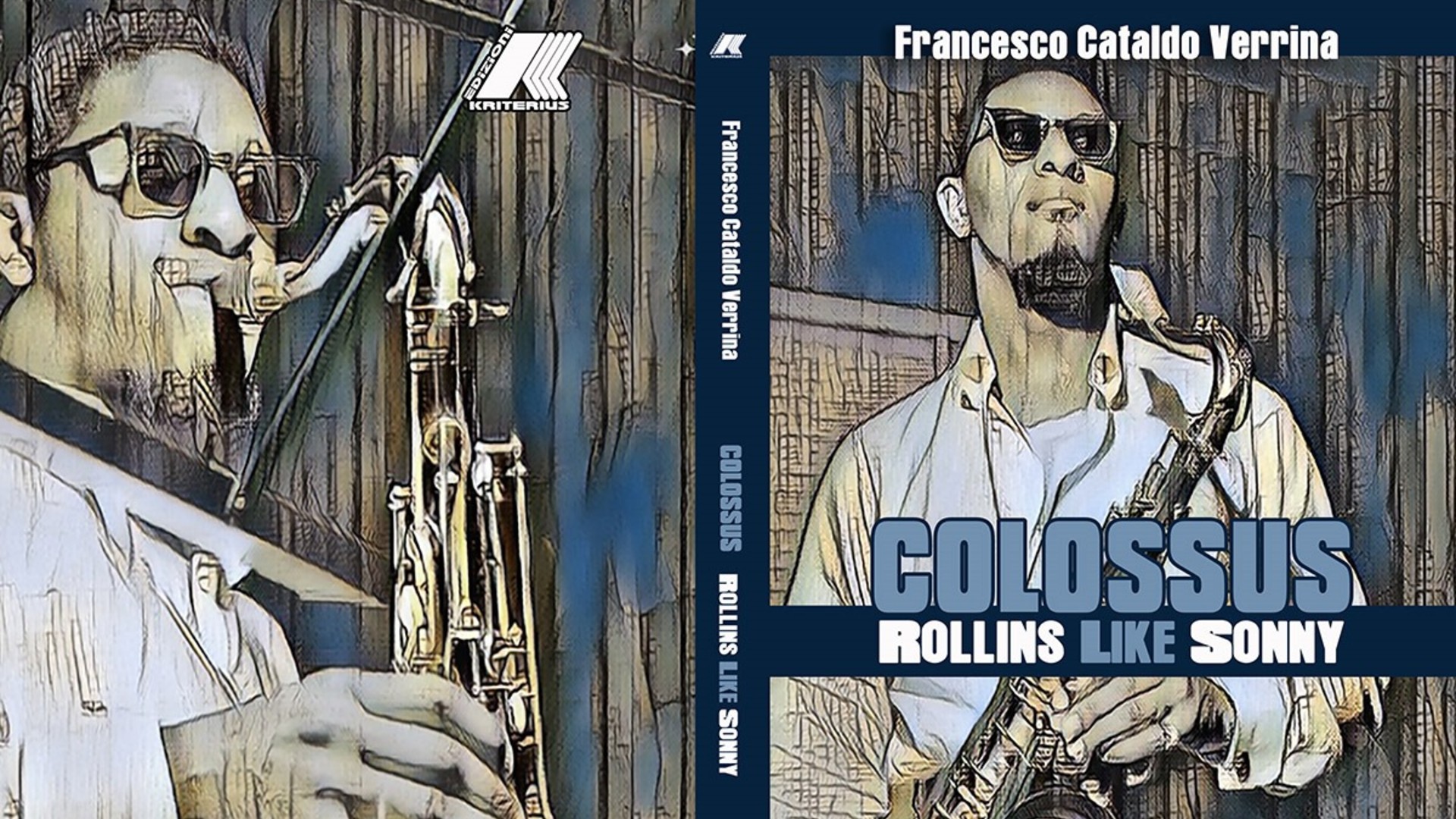Pubblicato da Kriterius Edizioni, «Art Pepper: sul filo dell’alta tensione» è un libro del critico musicale Francesco Cataldo Verrina. Si tratta del primo libro in italiano che racconta la storia del contraltista di Gardena, figura spesso accantonata e per certi versi incompresa. Dalle pagine del libro esce fuori un personaggio controverso raccontato attraverso la sua produzione discografica e una vita passata tra concerti, carcere ed eccessi. Ecco cosa l’autore ha raccontato a Jazz Around riguardo questo nuovo libro.
Personaggio controverso ma allo stesso tempo talento indiscusso. Cosa ti ha colpito maggiormente della figura di Art Pepper?
Premetto che essendo io molto afro-centrico non sono mai stato interessato, a livello di studio e di indagine, a quei jazzisti americani bianchi indirizzati verso forme di musica cameristica, sbiancata o riadattata altri contesti. Per contro, Art Pepper, personaggio a lungo frainteso e mal collocato nell’ambito di una nicchia di intrattenitori a sangue freddo o come espressione tipica del West Coast Jazz, fu uno dei primi contraltisti bianchi ad entrare nella mia sfera d’interesse per la sua innata e genetica blackness, di cui si tratta molto nel libro e su cui si forniscono dettagliate spiegazioni. Ovviamente sono stato colpito dal suo personaggio in tutta la sua complessità, tant’è vero che questo è l’unico libro in lingua italiana esistente sul mercato, scritto da un autore italiano.
Questo libro ripercorre la biografia attraverso la produzione discografica. Ci vuoi spiegare come hai deciso di strutturare quest’opera?
Più che biografia, parlerei di monografia: gli aspetti biografici sono di puro contorno e limitati all’essenziale. Sono gli aspetti ambientali che ruotano intorno ai dischi che in genere determinano il plot narrativo dei miei libri. I dischi vengono raccontati come se fossero i capitoli e la parte strutturale di un romanzo. A mio avviso, uno delle disfunzioni comunicazionali più ricorrenti in cui s’imbattono alcuni storici o scrittori a vario titolo, che porta ad una conoscenza del jazz, talvolta superficiale, è quello di trascurare la discografia o lasciarla come elemento di contorno, rispetto magari al fatto che il personaggio in oggetto fosse un ubriacone, che tardiva la moglie, si drogava, o che non si cambiava la biancheria intima, etc. Purtroppo su molti musicisti jazz esistono libri che sono più una raccolta di gossip che non un’analisi della loro opera musicale.
Un libro che in base a quello che abbiamo appreso è stato scritto a più riprese. Ci vuoi raccontare come hai lavorato alla sua realizzazione?
La mia tecnica di stesura è sempre la stessa. Ho una specie di «archivio», un contenitore di appunti accumulato in quasi quarant’anni di frequentazione della discografia e degli ambienti musicali, non solo jazz: recensioni, programmi radiofonici, uffici stampa, organizzazione eventi, interviste, ritagli di giornali, brevi impressioni legate ai concerti che ho visto, una collezione di oltre settemila vinili e migliaia di CD, che mi permettono di cogliere quasi in maniera viva e diretta l’essenza di chi suona (ha suonato) in quel dato documento sonoro, senza dover ricorre a surrogati digitali. Ti faccio un esempio: se mentre scrivi un libro su Art Pepper hai davanti a te circa quarantadue vinili e diversi CD, quasi tutta la sua discografia, diventa molto più facile scrivere e raccontare: tutto scorre. Per soddisfare la tua curiosità, ma lo scrivo anche nel libro, ci sono alcuni avvenimenti che risalgono alla seconda metà degli anni Ottanta, durante un’affollata e accaldata Umbria Jazz. In quei giorni di luglio, ci furono una serie di coincidenze che mi legano indirettamente ad Art Pepper: è come se avessi conosciuto una parte di lui.

A livello di stile e innovazione, secondo te Art Pepper che tipo di eredità ha lasciato?
Art Pepper non è stato un innovatore, ma un continuatore. Come tutti i contraltisti fece sua l’esperienza parkeriana, riuscendo ad andare oltre, già nelle prima parte della sua carriera, costruendo un linguaggio tutto suo attraverso una rimodulazione del bop, che raggiungerà livelli di espressione altissimi soprattutto nella parte terminale della sua vita, dopo una lunga interruzione carceraria legata al consumo e allo spaccio di stupefacenti. In quasi quindici anni di detenzione e riabilitazione Pepper non smise mai di suonare, studiare e migliorarsi, soprattutto il suo suo nuovo punto di riferimento divenne John Coltrane, ed è qui che il suo sound diventa una cosa altra, fugando completamente ogni residuo di jazz californiano. Dopo la metà degli anni Settanta, Pepper chiuse il percorso evolutivo arrivando al climax della «negritudine» a cui aveva sempre agognato per tutta la vita. Iniziato nel 1957 con l’avvicinamento all’hard bop di marca newyorkese proposto in «Meets The Rhythm Section» (disco realizzato insieme alla sezione ritmica di Miles Davis), il raggiungimento della blackness culminerà nel 1976 con le serate al Vanguard spalmate su quattro album, «The Complete Village Vanguard Sessions», che può essere considerata la sua massima opera discografica. Le parole di Pepper in proposito furono molto eloquenti: «Se riesco a resistere fino a 65 anni, non c’è dubbio che sarò io il nuovo punto di riferimento. Sarà la prima volta che un bianco diventa l’ispiratore di tutto il mondo del jazz». Purtroppo Pepper morì a soli cinquantasette anni nel 1982.
Una figura importante ma in Italia forse meno nota, come del resto tutta la scena anni ’50 della California. Perché la decisione di occuparsi di questa biografia?
Come ho spiegato, l’equivoco è proprio quello di considerarlo come un’emanazione del jazz californiano: a parte suonare all’inizio con musicisti locali, anche per ovvie ragioni pratiche, Pepper è sempre stato una sorta di nero-bianco (sangue italiano e irlandese), figura inquieta vissuta in maniera randagia in mezzo agli afro-americani e agli ispanici, cresciuta musicalmente sulla Central Avenue, dove suonava e faceva jam session sempre con musicisti di colore, di cui tornando a casa, davanti allo specchio, cercava di imitarne lo slang e gli atteggiamenti. Il suo primo vero maestro fu Benny Carter: nella sua musica c’è sempre stata – e si coglie già nei primi lavori – la rabbia e l’inquietudine dei quartieri malfamati, più simile al suono passionale e sanguinolento di Harlem che non al languore distaccato e vacanziero del Pacifico. Pepper non è mai stato il fratellino povero di Chet Baker, forse solo il fratello meno fortunato. E molti appassionati di jazz non sanno ciò che si perdono.
Quali sono gli aspetti più rilevanti di Art Pepper, sia da un punto di vista umano che musicale, che vengono sottolineati nelle pagine di quest’opera?
Personalmente considero Art Pepper come il più grande altoista bianco di tutti i tempi, uno dei pochi, insieme a Jackie McLean, ad ever trovato un sua voce ed un suo timbro su questo strumento, staccandosi subito dal modulo imposto da Bird. L’errore di una certa critica fu inizialmente quello di non voler uscire da questa zona comfort e valutare l’idea di un contraltista che si sforzava di liberarsi dalle catene del parkerismo. Fu molto più facile liquidare la pratica, parlando di jazz della West Coast. In quanto all’umanità di Art Pepper credo che emerga più dalla sua musica che non dalla sua esistenza vissuta sul «filo dell’alta tensione», come recita il sottotitolo del mio libro, in cui esistono molti punti oscuri e contrastanti che non possono certamente, per verità storica, essere elevati a modello di vita ideale.
Carlo Cammarella